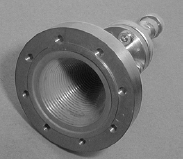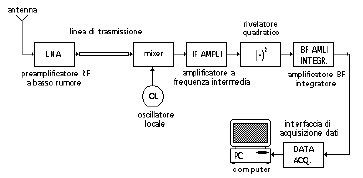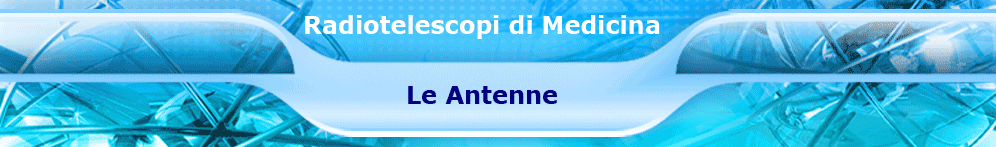 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
3. I Ricevitori
D’altro canto i feeds posizionati in fuoco secondario (focale lunga e angolo di vista stretto) hanno una dimensione limite oltre la quale finirebbero con l’illuminare aree al di fuori dello specchio secondario (che a sua volta dovrà avere dimensioni ridotte, per non ostruire eccessivamente lo specchio primario). Un compromesso è ottenuto posizionando in fuoco primario i feeds destinati alle basse frequenze (λ ≥ 10 cm) e in fuoco secondario i feeds destinati alle alte frequenze (angolo di vista più stretto).
Fig. 3.1 : Horn corrugato per la ricezione di microonde Una volta incanalato nella guida d’onda, il segnale raggiunge l’apparato ricevente, spesso attraverso un accoppiatore direzionale e un elemento in guida d’onda che separa le due polarizzazioni circolari, destra e sinistra. I ricevitori utilizzati in radioastronomia sono in maggioranza di tipo supereterodina, termine col quale, in questo contesto, si identificano tutti i ricevitori che convertono il segnale in ingresso (RF) in un nuovo segnale (IF) che mantenga la medesima informazione ma frequenza inferiore. La conversione si ottiene da un’opportuna combinazione del segnale RF con un segnale generato localmente ed è necessaria per ridurre le perdite durante la trasmissione (proporzionali alla radice della frequenza del segnale) e per facilitare l’elaborazione, difficilmente attuabile alle lunghezze d’onda centimetriche e millimetriche. All’interno dello stesso ricevitore si possono effettuare più procedimenti di conversione (downconversion) in cascata. L’elettronica necessaria a ottenere la IF è detta front-end e cambia a seconda della frequenza di osservazione, la parte che invece effettua l’elaborazione del segnale è detta back-end, ed è la stessa per tutte le frequenze. La struttura complessiva di un ricevitore si può sintetizzare nello schema in figura 3.2.
Figura 3.2 : Schema di un ricevitore supereterodina Per frequenze fino a 100 GHz il primo stadio dell’apparato ricevente è costituito da un amplificatore (Low Noise Amplifier – LNA) , tipicamente con guadagno di 25÷35 dB, in genere a semiconduttore (High Electron Mobility Transistor – HEMT). Il segnale radioastronomico è infatti per sua natura molto debole, tuttavia sopra ai 100 GHz i limiti tecnologici impediscono l’amplificazione diretta e occorre necessariamente amplificare il segnale dopo la conversione in frequenza Lo stadio successivo è costituito dal mixer (primo stadio per frequenze > 100 GHz), un dispositivo nel quale convergono il segnale radio e un segnale monocromatico, molto più intenso del primo, generato da un oscillatore locale a una frequenza vicina a quella del segnale originale (per ottenere un’elevata stabilità di fase occorre un segnale di riferimento fornito dall’esterno e l’oscillatore è detto Phase Locked Loop Local Oscillator – PLL/LO). E’ attraverso la moltiplicazione dei due segnali (RF ed LO), all’interno del mixer, che si realizza la conversione in frequenza. Quando due onde elettromagnetiche di diversa frequenza interagiscono all’interno del mixer il risultato non è la semplice sovrapposizione dei due segnali ma è un insieme di diverse combinazioni (dette “battimenti” in analogia con i fenomeni acustici) delle onde di partenza. Tra questi vi sono due segnali la cui frequenza è pari alla somma e alla differenza delle frequenze dei segnali in ingresso, hanno entrambi ampiezza linearmente dipendente dall’ampiezza del segnale RF e fase concorde (si dicono pertanto “armonici”), dunque rappresentano una buona stima del segnale originale e possono essere utilizzati per l’elaborazione.
νIF= frequenza del segnale all’uscita del mixer νLO= frequenza del segnale generato dall’oscillatore locale νS= frequenza del segnale all’ingresso del ricevitore Un filtro all’uscita del mixer seleziona l’armonica desiderata, e in questo caso il ricevitore è di tipo Single Side Band (SSB), più nel dettaglio si definisce Lower Side Band (LSB) qualora selezioni l’armonica “differenza” e Upper Side Band (USB) qualora selezioni l’armonica “somma”. Il filtro IF determina la banda di accettazione del segnale. Effettuata la downconversion il segnale IF viene nuovamente amplificato (amplificatore IF) e inviato al rivelatore. Poiché, come si è detto, il segnale radioastronomico si manifesta come una debole tensione rapidamente variabile in modo casuale, una semplice misura del suo valore medio nel tempo darebbe un risultato nullo. Un modo per ovviare a questo inconveniente è quello di utilizzare un dispositivo che non misuri semplicemente l’ampiezza del segnale ma che ne effettui in qualche modo il quadrato (Square Law Detector – SQLD). Il segnale in uscita dal rivelatore (proporzionale al quadrato del segnale originale) viene poi inviato a un integratore, che ne effettua la media su un determinato intervallo di tempo al fine di ripulirlo dal rumore introdotto dall’elettronica. Infine il risultato della catena di ricezione/rivelazione viene convertito in formato digitale e reso disponibile all’utente. In figura 3.3 le modifiche subite dal segnale RF attraverso i vari stadi di un ricevitore SSB.
Figura 3.3 : Step fondamentali nella ricezione di un segnale radioastronomico
|
|||||||||||
|
E. Cenacchi |
|||||||||||